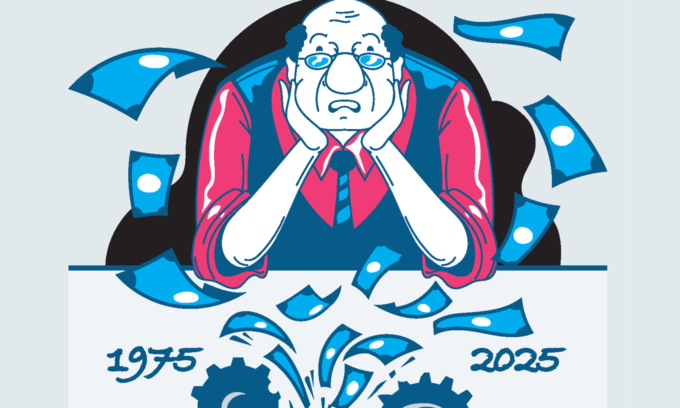Com’è possibile che, oggi, un chilo di pane costi più del triplo del suo valore rivalutato con l’inflazione? E perché, per una settimana al mare, spendiamo quanto un tempo bastava ad acquistare una moto? Questi interrogativi non sono affatto retorici: costituiscono il punto di partenza di un’analisi concreta e, a tratti, spiazzante. Il potere d’acquisto degli italiani si è progressivamente eroso – e non di poco. Fra la nostalgia delle vecchie “lire” e dinamiche economiche sempre più complesse, il confronto fra il 1975 e il 2025 rivela qualcosa che va ben oltre i numeri: una trasformazione silenziosa, ma profonda, della nostra capacità di vivere, consumare e risparmiare.
Attraverso l’analisi dell’indice dei prezzi al consumo (Cpi) e il confronto fra prezzi storici e attuali di beni e servizi di uso comune, emerge un quadro eloquente dei mutamenti economici avvenuti in cinquant’anni. Per ciascun bene considerato sono messi a confronto tre valori fondamentali: il prezzo originario del 1975 (espresso in lire), il prezzo rivalutato al 2025 tenendo conto dell’inflazione media (calcolata su un Cpi passato da 100 a 700) e, infine, il costo reale nel 2025, ossia quanto effettivamente paghiamo oggi. Secondo i dati, l’inflazione media in Italia ha fatto aumentare i prezzi di circa sette volte in questo arco temporale. In teoria, quindi, un bene che nel 1975 costava 100 lire dovrebbe oggi costarne circa 700 (pari a 0,36 euro) per mantenere lo stesso valore reale. Tuttavia, i dati mostrano che questa regola è stata spesso superata dai rincari effettivi: molte categorie di beni hanno registrato aumenti ben superiori alla semplice rivalutazione monetaria.
L’analisi dei singoli beni risulta particolarmente rivelatrice. Un chilo di pane, che nel 1975 costava 300 lire, oggi dovrebbe costare 1,08 euro; nella realtà ne costa circa 3,50. Un litro di benzina, passato da 350 lire a un valore rivalutato di 1,25 euro, si paga ora intorno a 1,70. Le auto utilitarie, come la storica Fiat 126, il cui prezzo di listino era 1.300.000 lire e che oggi varrebbe 4.700 euro rivalutati, sono state sostituite da modelli base che superano i 13.000 euro. Gli immobili mostrano l’aumento più marcato: un appartamento di 100 m² che nel 1975 costava 20 milioni di lire (circa 72.000 euro rivalutati) oggi richiede almeno 150.000 euro, spesso molto di più nelle grandi città. Anche il turismo ha subito un forte incremento: una settimana al mare per una persona, che costava 80.000 lire (400 euro rivalutati), oggi si aggira intorno ai 1.200 euro. Lo stipendio mensile di un impiegato, infine, è passato da 200.000 lire a un valore rivalutato di 728 euro; nella realtà, uno stipendio medio netto si attesta oggi sui 1.500 euro, un aumento che, pur superiore all’inflazione, fatica a tenere il passo con il generale rincaro del costo della vita.
In conclusione, questa analisi evidenzia come l’inflazione non abbia colpito tutti i settori allo stesso modo. Se da un lato gli stipendi sono cresciuti, dall’altro i beni e i servizi essenziali – dalla casa al pane, dalla benzina alle vacanze – hanno registrato aumenti ancora più marcati. Il risultato è una progressiva erosione del potere d’acquisto delle famiglie, soprattutto di quelle a reddito fisso.
Di chi è la responsabilità dell’erosione del potere d’acquisto? La risposta è che si tratta di una responsabilità sistemica, frutto di decenni di scelte economiche, finanziarie e politiche che hanno privilegiato la stabilità dei mercati a scapito del benessere reale delle persone. Oggi, le famiglie si trovano a dover pagare molto di più per vivere, senza che i loro redditi siano cresciuti in misura proporzionale. Comprendere questa dinamica non serve a individuare un capro espiatorio, ma a rivendicare la necessità di politiche più eque, sostenibili e lungimiranti.
Michele Porta