«Il terremoto, impietoso più della guerra»
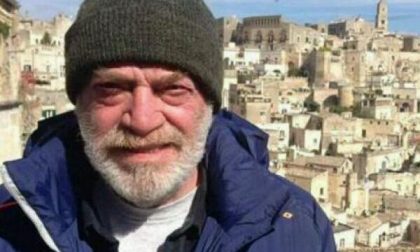
Il mio primo servizio da inviato fu in Montenegro, per un sisma, e mi ci mandò un piccolo giornale più come uno che aveva esperienza diretta del terremoto che come giornalista […] Ovviamente, seguii da cronista il terremoto dell’Irpinia […] e il terremoto dell’Abruzzo […] Ma, così come le guerre hanno risvegliato in me ricordi sepolti della mia infanzia, e del dopoguerra felice in cui sono cresciuto, ogni volta che ho dovuto raccontare un terremoto sono ritornato, silenziosamente, a quei giorni del 1976, al mio Friuli”.Toni Capuozzo (in foto) si descrive - è, quello sopra, un passo della prefazione da lui stesa per il libro “I farmacisti nel terremoto” di Elena Penazzi - come uno che “crede di conoscere i terremoti”. E quella parola, lui pluripremiato giornalista e noto inviato del Tg5 nonché conduttore del programma di approfondimento “Terra!”, la associa alla parola che, più di tutte, ha contraddistinto la sua carriera di narratore dei fatti del mondo: guerra.Raggiunto da “Eco di Biella”, spiega qui il motivo. Perché quello di Toni Capuozzo è uno dei nomi degli ospiti attesi in città venerdì, 5 maggio, e precisamente all’Agorà Palace Hotel, dove l’associazione locale “Inchiostro” - più volte in prima fila, per portare aiuti alle popolazioni colpite del Centro Italia - ha organizzato l’incontro “Cono d’ombra. Facciamo luce sul sisma del Centro Italia”. Incontro volto a tenere vivo il dibattito sulla situazione dei terremotati e, al contempo, a creare un’occasione utile alla raccolta fondi da destinare ai comuni colpiti dal sisma. Con Capuozzo, relatore e insieme moderatore, saranno, infatti, presenti i sindaci di Montegallo, Sergio Fabiani, e di Arquata del Tronto, Aleandro Petrucci, e il senatore Pietro Colonnella, già sottosegretario alla Presidenza dei ministri, già presidente della Provincia di Ascoli Piceno e presidente Corecon Marche e dell’associazione “Smart Piceno”.
Toni Capuozzo, il terremoto è una guerra?«Per me, il terremoto è peggiore di una guerra. In guerra, esiste un nemico contro cui puntare la colpa e esercitare la propria rabbia, l’odio e la vendetta e i peggiori sentimenti che si possono esprimere. Il terremoto, invece, è il tradimento della tua stessa terra: non è possibile prendersela con il fenomeno, se non con la poca previdenza degli uomini, ma davanti a un terremoto sei colpito alle spalle. E, in più, sei colpito nella casa, il tuo posto, il posto dove te ne stai solo con te, la tua “tana” sicura: è una paradossale ironia del destino. Io so anche cosa vuol dire un bombardamento, un combattimento, quando però mi è successo di essere colto da un terremoto in aperta campagna, dove non c’era motivo di temere il crollo di un edificio, mi è venuta meno l’idea della terra come elemento di sicurezza su cui poggiare. Il detto “sentirsi mancare la terra sotto i piedi”, pur non riferendosi al terremoto, è esattamente questo, è terribile. Chiaramente la casualità esiste anche in guerra, credo che è fortissima nella guerra che travolge tutto, ma in quel caso attorno a te c’è un mondo sconvolto; mentre con il terremoto tu sei in una tenda o in roulotte o in salotto e guardi in televisione un quiz o un servizio sulle elezioni, e succede qualcosa che allontana dalla normalità attorno. Ecco perché la gente delle aree terremotate chiede “non dimenticateci”: non è tanto per finanziamenti o aiuti, ma perché si sente come su un’isola a sé, in un mare di normalità».
Lei scrive che i terremoti “mostrano forze e debolezze di una società”: noi pensiamo di conoscerle, ma non sono poi sempre le stesse, purtroppo anche le debolezze?«Il terremoto è impietoso e mette a nudo con la forza di una radiografia. Uno dice “sto abbastanza bene”, finché fa gli esami e gli trovano qualcosa che non va, esami che normalmente non ci si fa se non ci si sente male. Mi ricordo del terremoto in Friuli e di un sindaco anziano bravissima persona, ma che non aveva la forza di reggere al compito straordinario di un terremoto, che ti coglie mentre hai un mutuo, sei in affitto o se hai risparmi o non ne hai. L’insieme della società, con un terremoto, riceve una radiografia spietata delle inefficienze e delle differenze. Il nostro è un Paese in cui la generosità non manca, lo si vede nelle sottoscrizioni ad esempio, ciò che manca è una pianificazione, si veda il lungo elenco di ricostruzioni mancate - se togliamo il Friuli - e di prevenzioni mancate. C’è un dissesto idrogeologico e investimenti non adeguati, c’è difficoltà a pensare a lungo termine, parliamo molto di giovani ma fatichiamo a pensare a due generazioni dopo di noi. Anche l’ultima è la radiografia di una comunità che stava languendo, perché la città sottrae energie e forze, posti di lavoro. La cosa importante non è che le case non si affloscino o che non si crepino, ma che non facciano crepare chi ci abita. Non ci si accorge di questo, finché non arriva il terremoto, una radiografia improvvisa».
In una recente puntata di “Terra!” si è soffermato su Emilia e Friuli, colpiti dal sisma nel 2012 e 1976, parlandone come di esempi. Quanto valgono oggi?«Dico innanzitutto che il Friuli è un posto dove molte cose funzionano, ma non so se sarebbe in grado di rifare ciò che ha fatto. Quella era una generazione molto forte, temprata dalle miserie degli anni Cinquanta e dal boom degli anni Sessanta, e anche la classe politica dava molti punti alla attuale. Allora si fece gruppo, sospendendo qualsiasi conflitto politico, e la Dc riuscì a coniugare la grande centralizzazione con il massimo della democrazia, perché i veri protagonisti, con totale responsabilità e controllo operato dal basso, furono i sindaci, e con loro la gente. Ciò ha snellito la burocrazia. Oggi, da un lato, siamo un Paese che porta le cicatrici di una corruzione che c’è sempre stata e, insieme, un peso fortissimo della vigilanza anti-corruzione, che è giusta ma nello stesso tempo rende più macchinosa la ricostruzione, che invece richiede decisioni veloci».
I terremotati, incontrati da “Inchiostro”, dicono di sentirsi dimenticati. Si corre il rischio di finire in un “L'Aquila bis”?«Ho passato molto tempo a L’Aquila. Le cose che mi colpirono - e io, sottolineo, ho sempre creduto che gli abruzzesi ce l’avrebbero fatta - ecco, in particolare, furono due: per prima l’assenza di un crudele realismo, di fronte al centro storico bisognava dire subito “ci vorranno trent’anni e non sappiamo se...”, altrimenti era illudere. Bisognava dire: “Rifare L’Aquila com’era sarà una impresa che riguarderà questa generazione e la prossima”. Nel frattempo, le cose cambiano, si sono rafforzati centri come Teramo, Pescara, non dimentichiamo la forza attrattiva della vicina Roma. O si inventavano qualcosa, come spostare tante altre Università a L’Aquila, oppure voleva dire mettere solo un cerotto. Allora, non si ebbe il coraggio di dire come stavano le cose. E la seconda cosa che mi colpì sono state le lotte politiche: molti remarono contro per non permettere a Berlusconi di fare bella figura su una ricostruzione rapida, chi sottolineava le cose che non andava andandole a cercare e quelle che andavano andandole a cercare. In mezzo ci fu una “informazione a tesi”, per tutti quanti. Su tutto, due letture: morte le ideologie, si è scatenata una guerra guelfi-ghibellini che non permette di dire verità intere».
Da dove ripartire, allora, adesso? Cosa dirà, per il futuro, durante l’incontro a Biella?«Credo che la solidarietà sia una cosa importante e che faccia bene a chi è il motore, e non solo al destinatario. Sono situazioni, queste, che vanno al di là del valore degli aiuti, perché ricordiamoci che c’è uno Stato che deve fare la sua parte: servono a fare in modo che le persone terremotate non si sentano dimenticate. Uno può anche non dare nulla, ma semplicemente ascoltare; loro sono persone che chiedono di essere ascoltate. Iniziative come questa, proposta a Biella, possono essere piccole scuole, per delineare come un Paese dovrebbe reagire davanti alle sue emergenze, senza una visione di destra e di sinistra, così come dovrebbe avvenire in molte altre questioni. Rischiamo di perdere il senso di comunità, importante in un quartiere o in paesino come in un Paese intero per la sua storia. Andare più in là dell’orizzonte visivo è importante, ci aiuta a sentire che siamo pur sempre un Paese, al di là di tutto. E io, personalmente, ho più fiducia nelle piccole iniziative che non nelle grosse».Giovanna Boglietti
Il mio primo servizio da inviato fu in Montenegro, per un sisma, e mi ci mandò un piccolo giornale più come uno che aveva esperienza diretta del terremoto che come giornalista […] Ovviamente, seguii da cronista il terremoto dell’Irpinia […] e il terremoto dell’Abruzzo […] Ma, così come le guerre hanno risvegliato in me ricordi sepolti della mia infanzia, e del dopoguerra felice in cui sono cresciuto, ogni volta che ho dovuto raccontare un terremoto sono ritornato, silenziosamente, a quei giorni del 1976, al mio Friuli”.Toni Capuozzo (in foto) si descrive - è, quello sopra, un passo della prefazione da lui stesa per il libro “I farmacisti nel terremoto” di Elena Penazzi - come uno che “crede di conoscere i terremoti”. E quella parola, lui pluripremiato giornalista e noto inviato del Tg5 nonché conduttore del programma di approfondimento “Terra!”, la associa alla parola che, più di tutte, ha contraddistinto la sua carriera di narratore dei fatti del mondo: guerra.Raggiunto da “Eco di Biella”, spiega qui il motivo. Perché quello di Toni Capuozzo è uno dei nomi degli ospiti attesi in città venerdì, 5 maggio, e precisamente all’Agorà Palace Hotel, dove l’associazione locale “Inchiostro” - più volte in prima fila, per portare aiuti alle popolazioni colpite del Centro Italia - ha organizzato l’incontro “Cono d’ombra. Facciamo luce sul sisma del Centro Italia”. Incontro volto a tenere vivo il dibattito sulla situazione dei terremotati e, al contempo, a creare un’occasione utile alla raccolta fondi da destinare ai comuni colpiti dal sisma. Con Capuozzo, relatore e insieme moderatore, saranno, infatti, presenti i sindaci di Montegallo, Sergio Fabiani, e di Arquata del Tronto, Aleandro Petrucci, e il senatore Pietro Colonnella, già sottosegretario alla Presidenza dei ministri, già presidente della Provincia di Ascoli Piceno e presidente Corecon Marche e dell’associazione “Smart Piceno”.
Toni Capuozzo, il terremoto è una guerra?«Per me, il terremoto è peggiore di una guerra. In guerra, esiste un nemico contro cui puntare la colpa e esercitare la propria rabbia, l’odio e la vendetta e i peggiori sentimenti che si possono esprimere. Il terremoto, invece, è il tradimento della tua stessa terra: non è possibile prendersela con il fenomeno, se non con la poca previdenza degli uomini, ma davanti a un terremoto sei colpito alle spalle. E, in più, sei colpito nella casa, il tuo posto, il posto dove te ne stai solo con te, la tua “tana” sicura: è una paradossale ironia del destino. Io so anche cosa vuol dire un bombardamento, un combattimento, quando però mi è successo di essere colto da un terremoto in aperta campagna, dove non c’era motivo di temere il crollo di un edificio, mi è venuta meno l’idea della terra come elemento di sicurezza su cui poggiare. Il detto “sentirsi mancare la terra sotto i piedi”, pur non riferendosi al terremoto, è esattamente questo, è terribile. Chiaramente la casualità esiste anche in guerra, credo che è fortissima nella guerra che travolge tutto, ma in quel caso attorno a te c’è un mondo sconvolto; mentre con il terremoto tu sei in una tenda o in roulotte o in salotto e guardi in televisione un quiz o un servizio sulle elezioni, e succede qualcosa che allontana dalla normalità attorno. Ecco perché la gente delle aree terremotate chiede “non dimenticateci”: non è tanto per finanziamenti o aiuti, ma perché si sente come su un’isola a sé, in un mare di normalità».
Lei scrive che i terremoti “mostrano forze e debolezze di una società”: noi pensiamo di conoscerle, ma non sono poi sempre le stesse, purtroppo anche le debolezze?«Il terremoto è impietoso e mette a nudo con la forza di una radiografia. Uno dice “sto abbastanza bene”, finché fa gli esami e gli trovano qualcosa che non va, esami che normalmente non ci si fa se non ci si sente male. Mi ricordo del terremoto in Friuli e di un sindaco anziano bravissima persona, ma che non aveva la forza di reggere al compito straordinario di un terremoto, che ti coglie mentre hai un mutuo, sei in affitto o se hai risparmi o non ne hai. L’insieme della società, con un terremoto, riceve una radiografia spietata delle inefficienze e delle differenze. Il nostro è un Paese in cui la generosità non manca, lo si vede nelle sottoscrizioni ad esempio, ciò che manca è una pianificazione, si veda il lungo elenco di ricostruzioni mancate - se togliamo il Friuli - e di prevenzioni mancate. C’è un dissesto idrogeologico e investimenti non adeguati, c’è difficoltà a pensare a lungo termine, parliamo molto di giovani ma fatichiamo a pensare a due generazioni dopo di noi. Anche l’ultima è la radiografia di una comunità che stava languendo, perché la città sottrae energie e forze, posti di lavoro. La cosa importante non è che le case non si affloscino o che non si crepino, ma che non facciano crepare chi ci abita. Non ci si accorge di questo, finché non arriva il terremoto, una radiografia improvvisa».
In una recente puntata di “Terra!” si è soffermato su Emilia e Friuli, colpiti dal sisma nel 2012 e 1976, parlandone come di esempi. Quanto valgono oggi?«Dico innanzitutto che il Friuli è un posto dove molte cose funzionano, ma non so se sarebbe in grado di rifare ciò che ha fatto. Quella era una generazione molto forte, temprata dalle miserie degli anni Cinquanta e dal boom degli anni Sessanta, e anche la classe politica dava molti punti alla attuale. Allora si fece gruppo, sospendendo qualsiasi conflitto politico, e la Dc riuscì a coniugare la grande centralizzazione con il massimo della democrazia, perché i veri protagonisti, con totale responsabilità e controllo operato dal basso, furono i sindaci, e con loro la gente. Ciò ha snellito la burocrazia. Oggi, da un lato, siamo un Paese che porta le cicatrici di una corruzione che c’è sempre stata e, insieme, un peso fortissimo della vigilanza anti-corruzione, che è giusta ma nello stesso tempo rende più macchinosa la ricostruzione, che invece richiede decisioni veloci».
I terremotati, incontrati da “Inchiostro”, dicono di sentirsi dimenticati. Si corre il rischio di finire in un “L'Aquila bis”?«Ho passato molto tempo a L’Aquila. Le cose che mi colpirono - e io, sottolineo, ho sempre creduto che gli abruzzesi ce l’avrebbero fatta - ecco, in particolare, furono due: per prima l’assenza di un crudele realismo, di fronte al centro storico bisognava dire subito “ci vorranno trent’anni e non sappiamo se...”, altrimenti era illudere. Bisognava dire: “Rifare L’Aquila com’era sarà una impresa che riguarderà questa generazione e la prossima”. Nel frattempo, le cose cambiano, si sono rafforzati centri come Teramo, Pescara, non dimentichiamo la forza attrattiva della vicina Roma. O si inventavano qualcosa, come spostare tante altre Università a L’Aquila, oppure voleva dire mettere solo un cerotto. Allora, non si ebbe il coraggio di dire come stavano le cose. E la seconda cosa che mi colpì sono state le lotte politiche: molti remarono contro per non permettere a Berlusconi di fare bella figura su una ricostruzione rapida, chi sottolineava le cose che non andava andandole a cercare e quelle che andavano andandole a cercare. In mezzo ci fu una “informazione a tesi”, per tutti quanti. Su tutto, due letture: morte le ideologie, si è scatenata una guerra guelfi-ghibellini che non permette di dire verità intere».
Da dove ripartire, allora, adesso? Cosa dirà, per il futuro, durante l’incontro a Biella?«Credo che la solidarietà sia una cosa importante e che faccia bene a chi è il motore, e non solo al destinatario. Sono situazioni, queste, che vanno al di là del valore degli aiuti, perché ricordiamoci che c’è uno Stato che deve fare la sua parte: servono a fare in modo che le persone terremotate non si sentano dimenticate. Uno può anche non dare nulla, ma semplicemente ascoltare; loro sono persone che chiedono di essere ascoltate. Iniziative come questa, proposta a Biella, possono essere piccole scuole, per delineare come un Paese dovrebbe reagire davanti alle sue emergenze, senza una visione di destra e di sinistra, così come dovrebbe avvenire in molte altre questioni. Rischiamo di perdere il senso di comunità, importante in un quartiere o in paesino come in un Paese intero per la sua storia. Andare più in là dell’orizzonte visivo è importante, ci aiuta a sentire che siamo pur sempre un Paese, al di là di tutto. E io, personalmente, ho più fiducia nelle piccole iniziative che non nelle grosse».Giovanna Boglietti